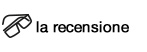
|
|
Per poter giudicare nel merito il lavoro di Anna Angelucci e Giuseppe Aragno è necessario, innanzitutto, comprendere la particolare prospettiva che gli autori hanno scelto per contestare in modo radicale le politiche di riforma scolastica in atto in Italia da ormai più di due decenni; e, aspetto ancora più rilevante, motivare le ragioni di questa scelta prospettica, incentrata sul lungo periodo.
La letteratura sulla scuola, in particolare quella che intende denunciare la strumentalità e l’infondatezza dei principi sulla base dei quali si vorrebbe, nel nostro Paese, rinunciare a una tradizione pedagogico culturale di grande spessore e tradizione, è ormai sterminata. Potrebbe ad alcuni sembrare addirittura ripetitiva, ma non è così; in effetti, alcuni testi che risalgono a più di due decenni fa, come quelli di Giulio Ferroni e Lucio Russo, non hanno perso affatto la loro attualità, e sarebbero da soli sufficienti a gettare uno sguardo significativamente critico sui presupposti politico-culturali perseguiti dai riformatori. Ma è proprio l’atteggiamento intellettuale di questi ultimi, indifferenti a tale patrimonio critico, a costringere a rinnovare queste analisi destrutturanti, e ad aggiornare l’atteggiamento critico in riferimento ai sempre nuovi contesti e provvedimenti che, senza sosta, mutano radicalmente in peggio il mondo dell’istruzione in Italia, senza peraltro riuscire a farlo in maniera definitiva.
Notiamo subito che il libro in oggetto parte da una valutazione decisamente pessimista; se all’epoca delle imprescindibili analisi di Ferroni e Russo l’intenzione era quella di lanciare un avvertimento al mondo della cultura, e mettere in guardia rispetto a un’azione politica che si presentava in modo evidentemente regressivo, oggi la «distruzione della scuola» -come recita il libro di un altro testo uscito quasi contemporaneamente[i]- è in parte già avvenuta, producendo mutamenti probabilmente irreversibili.
L’esigenza degli Autori è stata quella di indagare le radici storiche e culturali di tale trasformazione, per individuare la logica che ha reso possibile uno sconvolgimento privo di ragionevoli presupposti teorici, che non reggerebbero a un contraddittorio onesto, qualora ci fosse la possibilità di avviarlo. Un’esigenza di ricostruzione storica quanto mai avvertita in questa fase epocale, come testimonia anche il progetto del volume collettaneo La scuola dell’ignoranza, che è stato recentemente presentato e discusso proprio alla Casa della Cultura. La necessità di questo sguardo storico è quanto mai urgente, perché non solo presso l’opinione pubblica in generale, ma anche tra gli intellettuali, e persino tra gli stessi docenti, si fa fatica a scorgere il progetto unitario, la ratio, la coerenza profonda dei fini che sono stati perseguiti e in parte realizzati in questi due decenni. In effetti, a uno sguardo approssimativo, la strategia è sembrata spesso improvvisata e superficiale, e segnata anche da significativi fallimenti (dai grandi progetti di riforma targati Berlinguer e Moratti, sino alle strategie solo apparentemente diverse dei ministeri successivi). In realtà tale apparente incoerenza testimonia unicamente della difficoltà incontrate da questa azione politica, dovuta anche alla coraggiosa resistenza di buona parte della classe docente, che non ha accettato di rinunciare al proprio bagaglio professionale, immotivatamente delegittimato da tutti i sostenitori del pedagogismo.
Ma l’aspetto particolarmente interessante de Le mani sulla scuola, che lo distingue in parte da studi simili, sta nel fatto che la ricostruzione storica proposta non ha inizio con l’autonomia scolastica, ma parte addirittura dagli anni preunitari. Potrebbe sembrare uno sguardo retrospettivo eccessivo, sicuramente importante dal punto di vista della consapevolezza culturale, ma tutto sommato poco utile per rendere maggiormente consapevoli delle dinamiche attuali. In realtà non è così, in quanto, alla fine della lettura, ciò che si evince è una proposta interpretativa assolutamente coerente e, a nostra opinione, efficace.
Per comprendere la logica sottesa a tale impostazione, conviene partire da un’osservazione contenuta nell’Introduzione al volume, dovuta alla penna dello storico Piero Bevilacqua, il quale ricorda qual è la finalità autentica della scuola pubblica, senza conoscere la quale diventa difficile comprendere i motivi che nell’ultimo quarto di secolo hanno condotto scientemente a smantellare tale istituzione. La scuola, scrive Bevilacqua, «rimane la vera grande leva dell’emancipazione dei ceti subalterni e della mobilità sociale». Ora, dalla lettura dei capitoli dovuti alla penna di Giuseppe Aragno, emerge come la classe dirigente post unitaria si è impegnata proprio per contenere tale progetto emancipativo, per impedire che una sua piena realizzazione andasse a mutare la feroce diseguaglianza di classe e territoriale che presentava lo Stato italiano all’inizio della sua storia. Lo sguardo di Aragno si concentra esclusivamente sulla drammatica condizione delle regioni meridionali del paese, cioè su una situazione originaria di diseguaglianza della storia nazionale che non si è mai riuscita a risolvere, e di cui la politica scolastica rappresenta uno specchio fedele. Ma tale quadro storico, ampio e corroborato da tutta una serie di dati significativi, risulta essere anche un punto di riferimento adeguato, anzi obbligato, per intendere le strumentali finalità ideologiche della distruzione della scuola che avviene ai nostri giorni. Perché tra la storia di quel fallimento e la furia devastatrice che dagli anni Novanta perseguita la scuola italiana, vi è stato un momento in cui l’autentica finalità della scuola pubblica, sopra richiamata, fu perfettamente presente ai decisori politici, in questo caso ai padri costituenti. La “scuola della Repubblica”, o la “scuola della Costituzione” intendeva effettivamente eliminare tale insopportabile diseguaglianza. La scuola della Repubblica, la scuola della Costituzione, rimane punto di riferimento imprescindibile per concepire il ruolo dell’istruzione in una società democratica, proprio perché precisa che la finalità della scuola sta nel garantire «il diritto dell’alunno al rispetto pieno della sua personalità», ciò che era stato in buona parte disatteso negli anni post unitari. La scuola è dunque «diritto inalienabile della persona», l’«istituzione che più di ogni altra garantisce quella possibilità di uguaglianza e di pari opportunità nella vita sociale che non è data alla nascita»; l’istituzione che più può operare per rendere effettivo il secondo comma dell’articolo tre, e cioè garantire un’emancipazione intellettuale e materiale senza le quali non sarebbe possibile vivere concretamente quei diritti pure formalmente riconosciuti.
Ebbene, prima di proseguire nell’analisi del percorso proposto da Aragno e Angelucci, conviene avere presente il punto d’arrivo della loro fatica: la politica riformatrice sulla scuola, dai tempi dell’”autonomia scolastica” ai nostri giorni, intende effettivamente negare quelle finalità che la Costituzione assegna alla scuola e, sul modello delle classi dirigenti post unitarie, far sì che l’istituzione non metta a rischio la struttura gerarchica e disuguale della società che si è affermata in Occidente nel mondo globalizzato. Sarebbe interessante porre a confronto tale lettura con una considerazione più vasta dell’insofferenza che, già all’indomani del 1948, molti esponenti conservatori mostrarono verso la Carta costituzionale, nel momento in cui comprendeva al suo interno dei diritti sociali (anch’essi considerati diritti inalienabili), che essi avrebbero preferito fossero invece regolati dal leggi ordinarie. E in fondo tutti i tentativi di questi ultimi decenni di revisione costituzionale (compreso quello, purtroppo riuscito, della riforma del Titolo V) si sono mossi in tal senso. Nel caso della scuola, ciò che ci si propone è la presa di possesso dell’istituzione (le «Mani sulla Scuola» del titolo) da parte dei gruppi di potere privato, che vogliono controllare rigidamente l’istituzione, negarne la libertà di ricerca e di cultura, per asservirla ai propri interessi particolari, spacciati con noncuranza quali interessi collettivi. Ovviamente, come è proprio di ogni ideologia, tale trasformazione viene presentata in modo radicalmente opposto, definita coerente con lo spirito della Costituzione, attenta a combattere le disuguaglianze e a favorire l’inclusione; con argomentazioni poco fondate e in alcuni casi ossimoriche, come quando si pretende di coniugare e armonizzare fra loro atteggiamenti quali la “competitività” e la “inclusione”.
Ma, per ritornare alla “scuola della Costituzione”, tale lettura paleserebbe tutta la sua insufficienza se si limitasse a rimpiangere la scuola repubblicana, senza tenere conto dello scarto storicamente verificatosi tra i principi espressi nella carta e la loro effettiva realizzazione. Quelle speranze furono in parte disattese –e, ancora una volta, soprattutto nel Mezzogiorno-, e obbligano a rifuggire da qualsiasi tipo di mitizzazione di una realtà storica che è invece stata caratterizzata da forti problematicità e da una costante conflittualità. In particolare, il fatto che la scuola italiana continuò, nonostante le intenzioni, ad essere classista ed escludente. Sulle ragioni di ciò, però, si innestano tutta una serie di sviluppi e riflessioni, anche molto contraddittorie, senza conoscere le quali diventa difficile comprendere la palese demagogia con cui, nei nostri tempi, la trasformazione produttivistica e competitiva della scuola viene difesa come fosse una risposta democratica alla scuola classista della Repubblica. Sotto questo aspetto, l’analisi –condotta in questo caso in particolare da Anna Angelucci- risulta veramente precisa e rigorosa. Se quello spirito della Costituzione era autentico, come ricordano le splendide parole di Vittorini («la scuola può insegnare tutto ciò che occorre all’uomo per diventare soggetto di cultura e di coscienza, di libertà, di capacità creativa e di fede nel progresso comune»), pure la permanenza della “classi differenziali”, di docenti non epurati dal precedente regime, impedivano che tale quadro emancipativo andasse a coinvolgere in maniera efficace e ampia i ceti subalterni.
Nonostante ciò, i principi della Carta costituzionale rimangono un momento imprescindibile per comprendere il ruolo che deve caratterizzare la scuola in una democrazia repubblicana. Finalità che fanno impallidire la bassa retorica che accompagna l’introduzione, proprio per l’anno scolastico che va ad aprirsi, del nuovo curricolo di Educazione civica, che presenta tutt’altri scopi –come abbiamo già argomentato- che non quelli di valorizzare la personalità degli studenti nel senso espresso da queste parole di Vittorini: «Ma è nell’interesse della civiltà che anche il più umile lavoratore manuale si trovi, di fronte ai libri, di fronte alle opere d’arte, di fronte al pensiero scientifico e filosofico, di fronte alle ideologie politiche, di fronte ad ogni ricerca e ad ogni esperimento della cultura, nelle stesse condizioni di assimilabilità in cui funzionalmente si trova l’ingegnere, il medico o il professore». Tale dichiarazione, citata da Anna Angelucci, rappresenta uno dei momenti più alti in cui viene difeso il valore emancipativo del sapere disciplinare, l’immediato contenuto etico connesso allo studio dei saperi specifici, che oggi ridicolmente sono ritenuti incapaci di veicolare valori, a favore di approcci trasversali tanto impossibili da conseguire quanto privi di ogni tensione sociale e politica capace di offrire senso critico a chi li studia.
Lo spirito costituzionale, per quanto ostacolato da tutta una serie di non involontari impedimenti e difficoltà materiali, ha comunque contribuito a una forte acculturazione del nostro Paese, quanto meno a instaurare una consapevolezza critica diffusa. Uno dei momenti più significativi in questo senso–come viene giustamente ricordato- fu la riforma della scuola media unica. «Con l’abolizione dell’avviamento professionale e la prescrizione dell’obbligo scolastico a 14 anni […] ai bambini non fu più imposto quell’orientamento precoce tra studio e lavoro che, di fatto, fino a quel momento, ne aveva subordinato la maggior parte ai condizionamenti deterministici del contesto familiare […]. Con le sue criticità e imperfezioni, questa fu davvero una legge destinata a cambiare profondamente il profilo non solo della scuola italiana e dei suoi studenti, ma anche quello dell’intera società nel suo insieme e negli anni successivi». Pure la stessa Angelucci riconosce come «a dispetto dell’altro profilo politico e pedagogico che lo caratterizzava e della cornice costituzionale che ne legittimava il mandato», solo in parte il progetto raggiunse gli effetti auspicati. Le contraddizioni di sviluppo, in particolare al Sud, le differenze sociali enormi in un periodo storico di crescita economica dirompente solo in parte controllata nelle sue effettive conseguenze acuirono in alcuni casi i disagi. Fu in ragione di tali difficoltà che si svilupparono teorie che, pur partendo da una corretta analisi di contesto, fraintendevano drammaticamente, fino ad annullarli, i valori compresi nella dichiarazione di Vittorini. Lettere a una professoressa di don Milani, così come Le vestali della classe media. Ricerca sociologica sugli insegnanti, di Barbagli e Dei, risposero a tale drammatica situazione introducendo un bagaglio concettuale («astratto e concreto, ricchi e poveri, lingua e dialetto, teoria e prassi, tradizione e innovazione») che l’Autrice, in maniera condivisibile, considera quali «prodromi della regressione neoliberista della scuola deculturalizzata per tutti di oggi». Si tratta di un punto delicato, ma decisivo per sbarazzarsi di un equivoco di cui molti teorici delle riforme approfittano nella loro retorica giustificazionista. Ovvero quell’idea che il privilegiare il momento operativo rispetto a quello teorico, la concretezza dell’agire pratico rispetto alle riflessioni astratte, rappresenti di per sé una critica progressista a un’impostazione del sapere e della cultura conservatrice, trasferendo gli elementi di critica non a un’organizzazione che impedisce eguale emancipazione per tutti, ma agli stessi contenuti del sapere che, riservati fino ad allora a un élite che si imponeva come classe dirigenti, venivano essi stessi caricati di un plus valore ideologico considerato di per sé ostile alle classi subalterne. Un fraintendimento che ha pesato molto sulla cultura di sinistra che, non a caso, ha voluto a volte in maniera ancora più energica delle stesse forze conservatrici lo smantellamento dell’impianto culturale della scuola italiana. In realtà, tali problematicità non risolte non implicano affatto la messa in discussione dei contenuti disciplinari e del valore della cultura (e chi lo fa spesso non si rende conto di replicare quella pratica politica rappresentata in particolare dal lungo ministero Bottai, che si proponeva di smantellare la precedente esperienza gentiliana).
Il percorso storico proposto da Anna Angelucci procede rigoroso sino ad arrivare alle successive, fondamentali riforme degli anni Settanta, necessarie per rendere effettiva e per democratizzare una scuola ormai di massa: l’istituzione della scuola materna statale del 1968, i nuovi esami di maturità dello stesso anno e la liberalizzazione degli accessi all’Università, sino ad arrivare ai “Decreti delegati” del 1974. «La scuola diventa democratica, assume una dimensione partecipativa di natura collegiale, e tendenzialmente autonoma, e si avvia nella direzione di quell’identità comunitaria sociale e civica legata al territorio cui poi la politica la spingerà per altre ragioni, come vedremo, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, destinandola, forse anche per un’imprevedibile eterogenesi dei fini, verso le attuali forme di decomposizione e di frammentazione del sistema.» Come si evince da quest’affermazione, si prospetta già quell’esito paradossale per cui riforme concepite per affermare in via definitiva un principio realmente democratico e di massa, finiscono invece, nei decenni successivi, per offrire il destro a una direzione in senso contrario, come per esempio nel caso -cui qui si fa riferimento- delle autonomie regionali. Da un momento di controllo dal basso dell’organizzazione formativa, si giunge a utilizzare alcune strategie (il legame con il territorio, l’apertura della scuola al tessuto sociale) per esercitare un controllo sulla libertà didattica stessa, attraverso l’invasione di auto nominatisi stake holders, rappresentanti d’interesse che si arrogano il privilegio di dettare alla scuola le linee di comunicazione che dovrebbe applicare.
Detto ciò, è interessante ricordare l’accenno al progetto Brocca, giustamente definito «l’ultima ipotesi di una scuola ancora coraggiosamente declinata in una prospettiva culturale, in cui l’operatività delle attività didattiche non viene privata dei suoi fondamenti teoretici e scientifici, rifiutando qualsiasi impostazione esclusivamente addestrativa».
Dopo di che, dagli anni Novanta, inizia proprio questa deriva “addestrativa”, che le pagine successive seguono nel dettaglio. Vi è però, a questo punto, anche un aspetto diverso da considerare, che in parte spiega quella che poco sopra è stata definita «eterogenesi dei fini», per cui un bagaglio teorico nato con delle intenzioni emancipative finisce per diventare l’arma con cui la cultura e i poteri neoliberali mettono «le mani sulla scuola». Si tratta del nuovo contesto internazionale, con l’Unione europea che sceglie proprio un modello sociale improntato al neo liberismo per i suoi trattati fondativi, e che investono in questo senso in modo diretto il mondo dell’istruzione. Con il Libro bianco della Commissione europea presieduta da Jaques Delors e il Trattato di Lisbona ha inizio un processo teso a mutare radicalmente le finalità affidate alle istituzioni scolastiche, presso le quali deve prevalere «un’etica imprenditoriale», destinata a trasformare «l’essere umano in “risorsa umana” e le sue qualità in “capitale umano”», il «paradigma della performance e della valutazione», la concorrenza tra individui che si contendono le migliori posizioni nel mercato del lavoro. Due sono le osservazioni contenute a margine di questo excursus a nostro parere decisive: quella di «naturalizzazione» dell’attuale sistema produttivo e dell’ordine sociale che esso presuppone, che presuppone una riconfigurazione antropologica dell’individuo destinato a ricevere il processo d’istruzione, ma anche delle stesse figure docenti. A partire da questi documenti, e in ossequio a tali finalità, viene totalmente rifondato e stravolto in senso tecnocratico il lessico del mondo della scuola (nei documenti programmatici come in quelli legislativi). Un lessico volutamente anti filosofico, estremamente povero sul piano concettuale se lo si valutasse nei suoi effettivi fondamenti epistemologici, molto precari e che, come ha giustamente scritto Giulio Ferroni, ricordano una «ovvietà che si presenta come complessita»[ii]. La scelta di parte della sinistra politica di aderire a tale impostazione programmatica, ha condotto ad una risemantizzazione di alcuni vecchi concetti, come abbiamo visto già carichi di ambiguità nella loro originaria formulazione, per piegarli definitivamente alla logica tecnocratica e produttivistica. Per giungere infine alla «Buona Scuola», la Legge 107, che rappresenta solo l’esito definitivo di un processo di trasformazione dell’istruzione che si è totalmente allontanato dallo spirito della Costituzione. Si potrebbe a questo punto aggiungere, proprio a commento della Buona Scuola, un riferimento storico determinato; se è vero che quella legge è la trascrizione –in termini a dire il vero molto radicali e veramente iconoclastici verso il meglio della tradizione pedagogica e culturale del nostro Paese- dei principi contenuti nei documenti e trattati europei, dall’altra non possiamo non scorgere in questo legge uno spirito che è lo stesso con cui il ministro Bottai aveva proceduto allo smantellamento di fatto della scuola gentiliana. Senza citarlo, in parte questo viene affermato, quando si scrive: «il ritorno al binomio scuola-lavoro assume in questo senso il valore emblematico di un autentico ritorno al passato e riconduce ai drammatici processi di marginalizzazione di ampi strati sociali e di estese aree geografiche».
Detto ciò, non c’è dubbio che la Costituzione, per quanto colpevolmente contraddetta dalle politiche scolastiche degli ultimi venticinque anni, rimanga ancora in vigore; ed è grazie in particolare all’articolo 33, che ancora garantisce la libertà d’insegnamento, che la scuola italiana ha potuto non capitolare del tutto, e gli insegnanti non rinunciare al loro patrimonio professionale, mostrando nei fatti -anche agli altri appartenenti alla comunità scolastica- quanto l’involuzione di questi anni ha prodotto nella riduzione delle conoscenze e delle capacità delle generazioni più giovani
Nonostante ciò, il tono conclusivo del libro che stiamo presentando è piuttosto pessimistico: «L’implacabilità di un’autonomia “di mercato” altamente prescrittiva e regolativa, che riduce ogni spazio di libertà pedagogica […] ha reso la scuola oggi un concentrato illiberale di insopportabile omologazione conformista. Un luogo infelice, respingente, da cui tutti vorrebbero fuggire. Forse, dopo una breve stagione di speranze, insegnare a imparare è diventato veramente, e definitivamente, impossibile». Conclusione che richiama il titolo dell’ultimo libro di Giulio Ferroni dedicato alla scuola, La scuola impossibile, appunto.
Conclusione che avremmo in parte voluto attenuare nel suo tono privo di speranze, contando ancora su una, seppur molto provata, capacità di resistenza dei docenti italiani. Il fatto è che, tra la pubblicazione di questo libro e il nostro commento si è inserita la drammatica emergenza provocata dal Covid-19, che ha disarticolato la scuola nella sua organizzazione più profonda e autentica. E abbiamo assistito, commentandolo anche sul presente portale, a un cinico e progressivo tentativo di sfruttare l’emergenza per piegare in modo definitivo la resistenza degli insegnanti e distruggere completamente la scuola in senso anti culturale. La lettura di questo libro e degli altri che sullo stesso tema sono contemporaneamente usciti, deve servire ad evitare questo totale resa di chi sa di essere dalla parte della Costituzione e della cultura.
[i] Angelo Conforti, Scuola e televisione, il declino dell’Italia. La distruzione della scuola pubblica e del pensiero critico, CSA Editrice, Castellana Grotte, 2020.
[ii] G.Ferroni, La scuola sospesa, Einaudi, Torino 1997, pag. 95.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
24 AGOSTO 2020 |
